GIORNATA DELLA MEMORIA - MILANO: BINARIO 21
Per la Giornata della Memoria abbiamo pensato di parlarvi di un luogo che forse pochi conoscono: il binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Non è né una replica del binario 21 attualmente attivo in stazione né di un binario “qualsiasi”. Ma è il luogo da cui ebbe inizio l’orrore della Shoah a Milano.
 |
Binario 21 |
Ricordiamo che dopo l’armistizio dell'8 settembre 1943, firmato dal Regno d’Italia con gli alleati angloamericani, i tedeschi avevano occupato l’Italia settentrionale con la collaborazione dei fascisti, scegliendo l’Hotel Regina di Milano come loro quartier generale. Da lì coordinavano l’attuazione della “soluzione finale” della questione ebraica nei territori italiani controllati dalla coalizione nazifascista. Da quel momento, il Binario 21, fino ad allora utilizzato dai treni del servizio postale, fu convertito nella stazione di partenza dei perseguitati razziali e politici chiusi nel carcere cittadino di San Vittore. Il comando nazista locale, agli ordini del Capitano della Gestapo (la polizia segreta nazista) Theodor Saevecke, a cui sottostavano anche le bande fasciste della città, definì varie destinazioni per i prigionieri, applicando spesso la divisione tra ebrei e non ebrei: per i carri che trasportavano esclusivamente prigionieri ebrei, la meta era sempre Auschwitz, o comunque un altro campo di sterminio. Per gli altri deportati, l’arrivo più frequentemente scelto dagli occupanti era il campo di concentramento di Mathausen-Gulsen in Austria, e secondariamente quelli di Fossoli e Bergen-Belsen in Germania.
 |
Partenza e destinazione |
Tra il 1943 e il 1945, da questo binario partirono ventitré treni diretti ad Auschwitz e ad altri campi di concentramento. Nei vagoni vennero stipate migliaia di persone perseguitate dagli occupanti nazifascisti: erano soprattutto ebrei, ma anche partigiani e dissidenti politici. La sua posizione nascosta, al di sotto del manto stradale, permetteva di eseguire quasi di nascosto le partenze dei prigionieri.
Non è stato possibile ricostruire il numero preciso dei deportati che partirono dal Binario 21. Sappiamo che di tutti i viaggi che si susseguirono fino alla Liberazione nel 1945, il più impressionante e disumano fu quello che lasciò la stazione il 30 gennaio 1944, quando la soluzione finale era a pieno regime. Nei vagoni vennero stipati 605 cittadini italiani di famiglia ebrea. Il giorno stesso in cui raggiunsero il lager di Auschwitz-Birkenau, 477 di loro vennero uccisi nelle camere a gas. Gli altri 128 vennero immessi nel campo di concentramento. Di questi sopravvissero 14 uomini e 8 donne. Tra loro c’era anche Liliana Segre, che il 19 gennaio 2018, in occasione del settantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali, è stata nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Mattarella.
Il Binario 21 oltre ad essere un luogo della Memoria è diventato il Memoriale della Shoah di Milano e ad esso collegato c’è un progetto più ampio che ha lo scopo di rendere omaggio alle vittime dello sterminio e di far nascere un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. E, soprattutto, per non dimenticare.
Ad accogliere i visitatori c’è una grande scritta che non passa di certo inosservata. INDIFFERENZA. Questa parola è stata scelta con cura e sta a rappresentare il sentimento che, più di ogni altro, ha fatto patire gli ebrei: l’indifferenza della gente nei confronti di ciò che stava accadendo.
 |
Il muro dell'indifferenza |
Nel “cuore” del memoriale si trovano quattro carri merci dell’epoca, uguali a quelli che si avviarono alla volta dell’inferno. Lungo il Muro dei Nomi si trova una grande installazione in cui sono riportati i nomi delle 774 persone conosciute che vennero deportate: in bianco le vittime e in giallo i pochi sopravvissuti (22). I nomi non sono statici ma vengono messi in evidenza a rotazione, per restituire dignità a queste persone.
All’interno del memoriale c’è anche un luogo di riflessione, ricavato in una fossa di traslazione della stazione. Il suo interno è volutamente opprimente e buio (l’unico spiraglio di luce è una striscia che indica l’est) ed ha lo scopo di stimolare la riflessione ed il raccoglimento. Perché il memoriale non vuole essere soltanto un monumento alla memoria di chi non c’è più, ma anche un luogo per riflettere.
Il proposito di chi ha voluto e finanziato il progetto, infatti, era che il Memoriale non fosse un museo, ma un luogo di riflessione sulle persecuzioni e sull’indifferenza che ne permise l’attuazione, coerentemente con quanto affermato dallo Yad Vashem (l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah d’Israele): “Nella tradizione ebraica l’ordine di ricordare è categorico”.
Ed è per questo che vogliamo continuare a ricordare, come ci esorta Primo Levi nella poesia che apre "Se questo è un uomo":
Se questo è un uomo
Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango
che non conosce pace
che lotta per mezzo pane
che muore per un si o per un no.
Considerate se questa è una donna,
senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare
vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.
Primo Levi
La Redazione
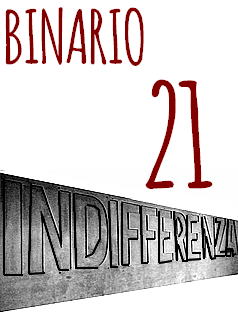

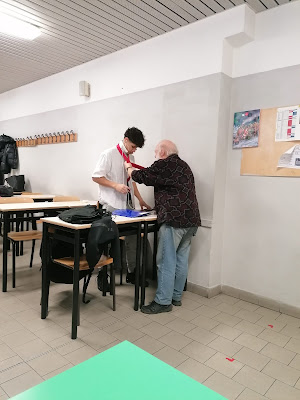

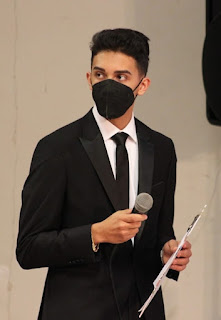

Commenti
Posta un commento